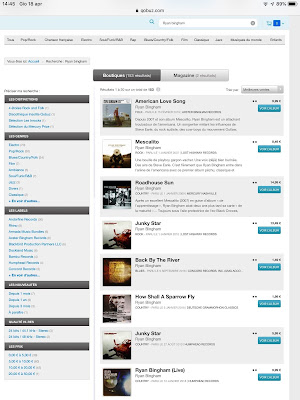Idea: per le frequenze basse, le piu' critiche e difficili da riprodurre, ma anche le piu' caratterizzanti, perché non aggiungere un subwoofer all'impianto invece che investire soldi e tempi nell'upgrade delle casse e, probabilmente, anche dell'amplificatore? Ce ne sono ormai molti, attivi, a prezzi molto economici. Un
subwoofer attivo, ovviamente, perché un sub passivo ha bisogno di un proprio amplificatore e quindi non può essere collegato a un tradizionale amplificatore stereo, che è invece il nostro obiettivo. Prima di impegnarci nell'avventura di aggiungere al nostro impianto un sub, è però meglio studiare le alternative che abbiamo a disposizione.
I subwoofer attivi sono di 2 tipi x 2 tecnologie
I sub offerti da un grande numero di produttori (è un settore di mercato fiorente, perchè è indirizzato anche all'home theater) possono essere bass-reflex (con accordo aperto o woofer passivo) oppure in sospensione pneumatica. La differenza con il settore dei diffusori è che i modelli a sospensione pneumatica sono in buon numero, anche se la maggioranza è ancora in bass reflex. Ci torno dopo su vantaggi e svantaggi (che più o meno si equivalgono).
Le tipologie invece fanno parecchia differenza. I sub possono essere dotati di input e di output oppure di solo input.
 |
| Un'ambientazione in pieno relax scelta da REL Acoustic per la pagina di confronto tra i modelli |
I sub con sole connessioni di input
Sono i più diffusi, anche se non necessariamente i più economici. Gli ingressi sono quasi sempre tre: 1 a basso livello stereo, 1 a basso livello mono e 1 ad alto livello. Quello mono (chiamato anche LFE) è pensato per la connessione ad amplificatori HT e bypassa il filtro passa basso, quindi non ci interessa (è adatto solo ad ampl HD. Lo stereo a basso livello è pensato per l'uscita REC dell'amplificatore, mentre quello ad alto livello consente, in alternativa, di connetersi all'uscita ad alto livello per i diffusori. L'audio in ingresso però sarà a gamma intera e quindi ci può essere sovrapposizione tra i woofer e il subwoofer. Nella pratica questi sub sono normalmente connessi all'uscita REC, l'altra opzione è riservata ai rari casi di amplificatore che ne è sprovvisto o di impianti in cui è già in uso. In ogni caso l'amplificatore dovrà avere uscite casse doppie (a meno di usare connettori a Y, cosa sconsigliabile a mio parere).
 |
| B&W sceglie invece un meno rilassante colore viola per il suo non convenzionale modello PV1D |
I sub con connessioni di input e di output
In questi modelli è possibile collegare nuovamente l'amplificatore o le casse a valle del filtro passa basso in modo da non inviare alle casse frontali le frequenze affidate al sub ed evitare sovrapposizioni. Per il collegamento linea (RCA) è necessario che l'amplificatore abbia ingressi pre e finale separati oppure la cosiddetta doppia barra di registrazione. In caso contrario dovrà essere usata l'uscita ad alto livello. Questa seconda opzione non è così negativa come può sembrare, il sub non fa altro che una connessione elettrica tra ingressi e uscita dopo un filtraggio passivo del tutto analogo a quello attuato dai crossover interni dei diffusori, e il carico offerto all'ampli è molto basso e non pone problemi. Questa seconda opzione non è però sempre presente.
Perché è necessario che il sub abbia ingressi e uscite
Il problema nell'utilizzo di un sub aggiuntivo ad un impianto hi-fi è l'incrocio alle basse frequenze. Se il sub ha solo ingressi la sua emissione, come anticipato, può sovrapporsi a quelle delle casse dell'impianto originale. Poiché l'emissione non è on-off ma ha una pendenza o salita più o meno accentuata, il sub dovrebbe essere relegato alla riproduzione di frequenze molto basse, ma col rischio di creare un "buco" di frequenze. In pratica è una soluzione tecnologica adatta per aggiungere le frequenze basse dove proprio non ci sono, quindi con impianti HT o anche stereo con mini casse frontali.
 |
| Del tutto convenzionale invece la foto di presentazione scelta da SVS per il suo potente sub SB 3000 con woofer da 30cm. |
Il problema dell'incrocio e la messa a punto
Quindi abbiamo un sub con ingressi e uscite e un amplificatore con uscita pre e ingressi finale separati, oppure un sub con input-output ad alto livello. A questo punto possiamo occuparci dei controlli messi a disposizìone per individuare e configurare l'incrocio ottimale, che sono:
- un crossover elettronico passa basso - passa alto con frequenza di taglio regolabile, per esempio da 50 a 200 Hz (ma pendenza fissa, di solito a 12dB/ottava)
- un controllo di volume
- un controllo di fase, regolabile con continuità da 0 a 180 gradi (oppure un interruttore 0-180)
La messa a punto è un processo che si deve affrontare per gradi, possibilmente in due (uno giudica il suono e l'altro regola i controlli o sposta il sub) iniziando dalla regolazione della fase e finendo con quella della frequenza di taglio del crossover. In alternativa possono essere usati un fonometro e altri strumenti di misura, a cura magari di uno specialista. L'appassionato preferirà invece occuparsene lui, a questo scopo in appendice è disponibile una guida che sembra molto chiara e pratica, che ho tradotto dai manuali dei sub REL Acoustic, rinomata casa inglese specialista del settore.
La localizzazione
La localizzazione del sub è da evitare, non si deve percepire dove si trova, in altre parole. Se invece riusciamo a individuare la sorgente delle frequenze basse affidate al sub, ovvero si percepisce una variazione quando si sposta il componente, bisogna intervenire sulla regolazione della fase e sulla regolazione di incrocio per farlo nuovamente "sparire". Tipicamente è stato scelto un taglio troppo in alto o ci sono problemi di fase.
 |
| Un'altra raffinata ambientazione scelta da REL Acoustic per il suo modello top. La casa inglese specializzata in sub (produce solo quello) investe molto nella comunicazione per immagini presente sul proprio sito. |
Una verifica sul nostro impianto
Prima di imbarcarsi nell'acquisto e nella installazione di un sub conviene accertarsi in modo più oggettivo, rispetta alle impressioni musicali, delle reali prestazioni sui bassi del nostro impianto. Anche per avere un'idea di dove dovrà essere posizionata la frequenza di taglio, senza andare necessariamente per tentativi. La curva risposta sui bassi delle nostre casse dovremmo conoscerla, o perché era riportata nel manuale o grazie alle prove di qualche rivista. Ma ascoltarla e verificarla con il nostro sistema uditivo non fa male, ed è anche molto semplice.
Il disco test
Per farlo basta avere un disco test con una serie di frequenze basse, non dobbiamo giudicare la qualità del suono, ma solo se sentiamo qualcosa, e come. Stranamente i dischi test forniscono di solito un'unica traccia con tutte le frequenze e per riconoscerle una dall'altra bisogna contare.
Sarebbe più pratico avere una traccia per ogni frequenza, senza andarlo a cercare l'ho realizzato io, creando un disco test su misura, che ho messo a disposizione (con altri test) sul sito
Audio-Clips. Le frequenze o note campione scelte sono elencate nel seguito, il link per scaricare i file audio e creare un CD test
è questo (vedi "Gamma frequenze basse"):
- 196 Hertz 25sec - violino.wav
- 65 Hertz 26sec - violoncello.wav
- 43 Hertz 27sec - basso tuba.wav
- 41 Hertz 26sec - contrabbasso.wav
- 31 Hertz 20sec.wav
- 29 Hertz 26sec - controfagotto.wav
- 27.5 Hertz 26sec - piano.wav
- 25 Hertz 20sec.wav
- 20 Hertz 20sec.wav
- 16.3 Hertz 27sec - organo.wav
Ogni campione è ripetuto 3 volte in modo da avere il tempo di ascolto e per l'eventuale azione del volume. Perché non bisogna scordare che i diffusori, tutti, hanno un progressivo roll-off (caduta) sulle basse. Per esempio un diffusore con risposta da 40Hz a 20KHz entro 3dB a 40Hz avrà già un volume di 3dB inferiore a quello medio (e pobabilmente a 60 Hz saranno già 6dB).
Nella pratica per ascoltare le frequenza basse man mano che andiamo fuori dalla risposta in frequenza garantita bisognerà alzare il volume.
 |
La risposta italiana è affidata soprattutto
a Indiana Line con i suoi modelli Basso.
Questo è il Basso 880 (reflex) |
Le frequenze
I campioni scelti, che sono tratti dal noto disco test della RCA, sono molto "musicali," nel senso che hanno scelto le note più basse che possono essere emesse dal violino, dal violoncello ecc. fino al cotrofagotto e all'organo. Poiché qualche volta in qualche opera musicale queste note saranno pure state usate, può essere utile verificare se il nostro impianto è in grado di riprodurle o le taglia proprio, e cosa cambia aggiungendo un sub.
Il test
Molto semplicemente bisogna solo ascoltare le tracce partendo dalle più alte. Ascolteremo senz'altro senza problemi le prime due, magari la nota bassa del violoncello (65Hz) un po' attenuata. Scendendo dovremo cominciare ad agire sul volume, per compensare il roll off. La risposta in frequenza delle mie casse (Kef 103/4) è 50Hz-20KHz entro 2,5dB, e così a 43 Hz (basso tuba) ho dovuto iniziare ad alzare il volume. E ho continuato ad alzarlo fino al campione a 25Hz, l'ultimo che i diffusori riuscivano a riprodurre. Ma già da frequenze sotto i 30Hz in realtà il mio sistema uditivo non ascoltava un suono proveniente dalle casse. Quello che si percepiva era invece l'effetto delle onde sonore a frequenze molto basse. Per esempio a 29 e 27,5Hz quello che sentivo era la vibrazione dei vetri sopra la porta di un'altra stanza a diversi metri di corridoio (mentre io ascoltavo nella sala) eccitata non si sa come dalle onde stazionare emesse dalle Kef.
Da aggiungere che il volume del mio amplificatore (che è piuttosto potente, 70W) era già a 3/4 e quindi a un livello inaccettabile in un appartamento (e non so quanto dai diffusori).
Un test molto istruttivo, tra l'altro ha confermato la risposta in frequenza (misurata nei test fatti dalla rivista Stereophile), riportata in figura.
La tecnologia
Come anticipato ci sono sub in
bass-reflex e altri in
sospensione pneumatica.
In pratica vantaggi e svantaggi si equivalgono, nel comune obiettivo di garantire una risposta in frequenza molto estesa sui bassi con dimensioni e costi contenuti. La sospensione pneumatica ha il vantaggio di non richiedere un condotto di accordo che a frequenze basse può richiedere lunghezza e ampiezza difficili da conciliare con il mobile compatto (a volte i progettisti usano per risovere il problema un woofer passivo). La estensione, ovvero la compensazione del roll-off, si ottiene facilmente con l'equalizzazione (lo stesso vale per i bass-reflex) e la potenza necessaria (elevata) non è un problema ora con il generale utilizzo per i sub di amplificatori in classe D.
Il vantaggio per i bass-reflex è invece il costo, meno stringenti a parità di prestazioni di targa le esigenze di potenza dell'amplificatore, di escursione dell'altoparlante, di robustezza e indeformabilità della cassa. Quindi scelta libera a parità di serietà di realizzazione, anche se chi cerca bassi il più possibile controllati (come me) preferirà probabilmente sub a sospensione pneumatica, visto che esistono e sono abbastanza diffusi, a differenza di quello che avviene tra i diffusori.
In sintesi
Quindi è tutto chiaro. Basta trovare un sub con ingressi e uscite e qualità adeguata che non costi uno sproposito, e provare.
 |
| Ancora un modello T della REL Acoustic, qui in versione bianca, in camera anecoica |
Appendice. Guida alla installazione e messa a punto di un subwoofer per un impianto audio
1. Posizionamento: la posizione ottimale per il sub è in uno degli angoli dietro i diffusori principali. Questa posizione fornisce 9 dB di amplificazione meccanica e consente la diffusione più lineare delle basse frequenze, grazie alla possibilità di sincronizzare il sub sulla lunghezza maggiore della stanza e quindi generare anche le forme d’onda delle frequenze più basse.
2. Il processo da seguire. Per iniziare il processo di set-up, scegli un brano musicale con una linea di basso ripetitiva che abbia una frequenza molto bassa. Ti consigliamo la traccia 4 dalla colonna sonora di Sneakers (Columbia CK 53146). Questo ha un battito di batteria sul basso ripetitiva che dà molto tempo per spostare il sub cercando la posizione ottimale, ma ancora più importante, la sede della registrazione era abbastanza grande per questa registrazione, e quindi ha una immagine dei bassi molto profonda ed ampia. Questo tipo di traccia è perfetto per il processo di set-up e dovrebbe essere riprodotto al più alto livello ragionevole previsto per la riproduzione del sistema. Lavorare con un partner, uno nella posizione di ascolto e uno vicino al sub che opera sui controlli, è il modo più efficace ed efficiente per impostare il sub. Se si lavora da soli, i passaggi iniziali nel set-up possono essere eseguiti in modo molto efficace dalla posizione del sub. Cercando di ignorare tutta l'altra musica nella traccia, ascolta la cassa della batteria e il suo effetto nella stanza d'ascolto.
3. Messa a punto della fase: una volta installato e attivato il sub dobbiamo regolare la fase. Questo potrebbe essere il passo più critico, e poiché è in realtà molto semplice, è spesso affrontato con troppa preoccupazione. Tieni a mente: la fase corretta è quella in cui il suono è più forte o più pieno. Mentre si riproduce musica con veri bassi profondi, regolare il crossover in un punto in cui il sub e l'altoparlante condivideranno sicuramente le frequenze (circa a metà del potenziometro del crossover ovvero a ore 12 o leggermente più in alto per i diffusori più piccoli. A questo punto ruotare il controllo di volume HI / LO in modo che sia il sub che i diffusori abbiano un volume approssimativamente uguale e quindi commutare lentamente, usando il potenziometro di fase, da posizioni di fase "0" a "180". Ancora una volta, qualunque posizione sia la più alta o la più piena, è la posizione corretta. Cioè, quando la posizione funziona in armonia con i diffusori principali, rinforzando i bassi e non cancellandoli.
(Nel caso frequente di sub che hanno invece solo un interruttore di fase con due posizioni, 0° o 180°, le istruzioni sono diverse, queste sono del Velodyne Impact:
Questo controllo consente di "invertire" la fase del segnale di uscita del subwoofer di 180 ° per correggere per quanto possibile mancata corrispondenza e risultante annullamento tra il subwoofer e i diffusori principali. Per regolare la fase, semplicemente ascoltare il sistema con la riproduzione musicale, quindi premere l'interruttore di fase da una posizione all'altra e ascoltare come cambia il livello di uscita dei medio bassi. La posizione corretta avrà una quantità maggiore di medio bassi. Se le impostazioni sembrano simili, lasciare la posizione "0".)
4. Posizionamento: il passo successivo è determinare con esattezza quanto lontano dall'angolo debba essere posizionato il sub per ottenere l'uscita più efficiente, così come la risposta in frequenza più bassa. Con il sub completamente nell'angolo, e puntando verso l'esterno lungo la diagonale uscendo dall'angolo, continuando a suonare la musica, spostare lentamente il sub dall'angolo sulla diagonale, equidistante da entrambi i lati e dalla parete posteriore. Ad un certo punto (a volte solo pochi centimetri, in rari casi un piede o poco più) l’uscita del sub arriverà più in basso, suonerà più forte, e, se lo blocchi nella stanza e il sub la riempie completamente di suono, l'aria intorno al sub sembrerà essere energizzato, allora fermati proprio lì! Questa è la posizione corretta dall'angolo per il sub.
5. Orientamento: una volta stabilita la posizione dall'angolo, l'orientamento del woofer deve essere determinato ruotando il sub da un immaginario punto centrale sul retro. Quando il sub viene spostato da un lato all'altro, si ascolta il massimo livello di uscita e la linearità del basso. In effetti, il sub dovrebbe essere lasciato nella posizione in cui sta suonando più forte e con la più ampia estensione verso il basso.
6. Impostazioni del crossover e del volume: per determinare il punto di taglio del crossover, portare il volume del sub (usando il controllo del livello HI / LO) completamente verso il basso e posizionare il crossover su 25 Hz. A questo punto, riporta lentamente il volume del sub al punto in cui hai raggiunto un equilibrio appena accennato, cioè il punto in cui puoi sentire il REL anche se i diffusori principali suonano. Ora porta il taglio del crossover fino al punto in cui è troppo alto; a questo punto portalo alla giusta impostazione intermedia inferiore. A tutti gli effetti, questo è il punto di crossover corretto. Una volta raggiunto questo livello, è possibile apportare lievi modifiche al volume e al crossover per fornire l'ultimo bit di integrazione completa e senza discontinuità. Con ciò, il set-up è completo.
Suggerimento: potrebbe esserci una tendenza a impostare il punto di crossover troppo alto e il volume del sub troppo basso nei primi passi di integrazione del sub con l’impianto, il timore è di sopraffare i diffusori principali con i bassi. Ma così facendo, il set-up risultante sarà privo di profondità e dinamica dei bassi. Il corretto punto di crossover e l'impostazione del volume aumenteranno invece le dinamiche generali, consentiranno l'estensione delle basse frequenze e miglioreranno il realismo del palcoscenico virtuale. Nota, il volume deve essere regolato insieme alle modifiche del crossover. In generale, quando si seleziona un punto di crossover inferiore, potrebbe essere necessario alzare il volume.