Il nuovo corso della rinata rivista Audio Review ha imposto a parecchi appassionati di alta fedeltà un certo numero di pagine dedicate all'alta fedeltà in auto, curate dai redattori della ex rivista Audio Car Stereo (ACS), incappata, come AR, nel fallimento della casa editrice dello storico magazine (leggi in
questo precedente post e nei commenti la storia).
La maggior parte dei cultori dell'hi-fi rifiuta a priori il concetto di ascoltare la musica preferita in una situazione così poco favorevole, a quanto si sa. Ma qualcuno, forse mosso dalla curiosità, potrebbe porsi la domanda se l'alta fedeltà, o qualcosa che vi si avvicini, sia possibile in queste condizioni.
 |
Una delle poche vetture che può fare a meno di
un impianto hi-fi custom, perché monta di serie un raffinato sistema
audio B&O: la BMW Serie 6 (con la consorella serie 7).
Chi non ne ha una in garage può provare a leggere questo post. |
Gli ostacoli
Effettivamente parecchi impedimenti si frappongono al raggiungimento di questo obiettivo: a) un ambiente d'ascolto ingombro di ostacoli fisici (i sedili, i poggiatesta, gli stessi passeggeri) b) la disponibilità di una sorgente di energia (la batteria) limitata a 12V c) la mancanza dello spazio fisico per collocare l'impianto ed in particolare i diffusori per le basse frequenze d) l'elevato rumore di fondo in movimento che limita la gamma dinamica disponibile, e) la posizione laterale di chi ascolta e, infine il più recente e forse ormai prevalente: f) la presenza ormai generalizzata di un impianto di serie spesso integrato con il navigatore e il computer di bordo, non modificabile e non sostituibile.
I vantaggi
Esistono però anche alcuni elementi a favore di un impianto car auto rispetto ad uno fisso: a) lo spazio limitato dell'abitacolo, che rende più facile raggiungere livelli di pressione sonora adeguati, soprattutto alle frequenze inferiori, b) la disponibilità del luogo: almeno per i non single, per ascoltare a casa la musica bisognerà fare i conti con gli altri componenti della famiglia, se l'impianto è nella stanza del televisore principale, o se, in caso diverso, si vuole evitare di passare per asociali, c) la possibilità di ascoltare generi musicali non graditi ("
le donne non amano il jazz, non si è mai capito il motivo" cantava in una canzone di qualche anno fa Paolo Conte).
Un'idea da non scartare a priori
Può valere la pena, quindi, prendere in considerazione il montaggio di un impianto hi-fi sulla nostra auto, soprattutto per chi viaggia di frequente e con percorsi non troppo corti e da solo (o con compagni di viaggio con gli stessi interessi). Essendo però preparati ad investire una cifra non indifferente. Un impianto car audio che si possa definire hi-fi parte infatti da livelli di costo più elevati di un impianto di casa, e richiede di rivolgersi ad un installatore professionale.
Senza voler entrare nei dettagli e senza voler scrivere qui una guida (inutile se si ricorre ad un installatore) ma con l'obiettivo unicamente di fornire le informazioni di base, vediamo come sono stati superati negli anni gli ostacoli (quelli superabili).
Ambiente d'ascolto
Per quanto grande sia l'auto non sarà mai l'ambiente ideale per ascoltare una ricostruzione spaziale realistica. Occorre rinunciarvi. Anche le casse posteriori non aiutano, non sono lì per l'ambienza, ma per far ascoltare la musica anche ai passeggeri seduti dietro. I processori digitali consentono però di riposizionare l'immagine stereo collocandola al centro per chi guida.
Alimentazione a 12 Volt
Limita la potenza disponibile per un amplificatore di tipo tradizionale (come quelli di casa) a 4-8W. Da anni però il problema è risolto con varie tecnologie (come il survoltore) e sono disponibili in commercio amplificatori per auto di potenza anche superiore a 100W. Ma che costano ovviamente di più, in proporzione alla qualità, di quelli da casa che funzionano a 220V.
 |
Un amplificatore per auto da 450W della casa tedesca
specializzata Gladen Zero |
Lo spazio fisico
I diffusori anteriori e posteriori devono essere sostituiti, ma quelli nuovi con caratteristiche hi-fi possono utilizzare gli stessi vani e cavità usati per quelli di serie. Tutto il resto deve però trovare posto nell'abitacolo o nel bagagliaio, dove però non sono previsti spazi per componenti aggiuntivi. Che, in dipendenza della struttura dell'impianto, possono essere anche 3 o 4. Ad esempio due amplificatori (a 4 e/o 2 canali) per i diffusori anteriori e posteriori, un processore digitale (vediamo dopo a che serve), un subwoofer amplificato (o due, magari con propri amplificatori). In generale si può dire che gli impianti per auto sono di livello e complessità più elevati di un impianto di casa anche medio alto. Amplificatori dedicati per ogni canale, crossover elettronico, subwoofer attivi, processori dedicati, altoparlanti realizzati con le più recenti tecnologia sono la norma. L'installatore esperto progetterà l'impianto personalizzato per l'auto e individuerà la posizione ottimale per i componenti concordandola con il proprietario. Parte dello spazio sarà sacrificato, ma con componenti scelti tra la vasta produzione mondiale specializzata si potranno salvaguardare le funzionalità di base (posti a sedere, trasporto di bagagli) e l'impianto originale. Vediamo brevemente come.
 |
| Un altoparlante specializzato per sub car-audio della francese Morel |
L'impianto originale
È composto per la parte audio da una o più sorgenti (radio, lettore CD, ingresso analogico aux, spesso interfaccia per iPhone) un decoder digitale analogico e una sezione di amplificazione. Idealmente bisognerebbe collegarsi all'uscita del DAC ma quasi mai ciò è previsto dal costruttore dell'auto. Intervenire sull'unità e' altamente sconsigliabile e fa decadere la garanzia su tutta la parte elettronica e quindi non è applicabile sulle auto nuove. La soluzione più semplice e' collegare un processore digitale all'uscita della sezione di amplificazione, per ognuno dei 4 canali normalmente esistenti. Può sembrare una soluzione poco audiofila, perché il segnale subisce due conversioni e una amplificazione inutile da parte di un componente non di qualità eccelsa come il sintolettore di serie, ma è la più pratica, e quasi l'unica, e il risultato è valido musicalmente.
Anche perché in questo modo le successive complesse operazioni necessarie per il filtraggio tra le tre vie e la equalizzazione del segnale saranno svolte nel dominio digitale dal processore, che piloterà poi direttamente i canali dei vari amplificatori finali.
 |
| Un potente processore digitale della italiana Audison |
I componenti custom-fit
In alternativa per alcune marche e modelli sono realizzati da case specializzate componenti progettati esattamente per sostituire il navigatore più unità audio-video di serie. Sono progettati specificamente perché ogni casa automobilistica adotta protocolli di comunicazione e standard di installazione diversi. Sono disponibili ad esempio per buona parte della produzione Volkswagen. Il componente di serie sarà poi reinstallato al momento di vendere o restituire l'auto. Si tratta di una soluzione tecnicamente superiore, anche come interfaccia utente, ma ovviamente anche molto più costosa.
I finali
L'impianto di un'auto standard ha quattro canali (2 anteriori e 2 posteriori) ciascuno dei quali normalmente a 2 vie (woofer e tweeter). L'impianto custom aggiunge sempre un sub woofer e quindi una via e due canali in più. Un impianto di buon livello con crossover attivo richiede quindi 6 finali stereo. Usando per maggiore semplicità un crossover passivo per i canali posteriori si possono ridurre a 3, e a 2 utilizzando un subwoofer attivo.
I finali per auto sono realizzati in modo da ridurre al minimo l'ingombro, quindi di solito "a sogliola" pochi centimetri di altezza per 60-80 di lunghezza. Ma trovare il posto per 2 o 3 unità più il processore digitale non è semplice. Lo spazio di può trovare riducendo il bagagliaio con un doppio fondo o rialzando il pavimento per i sedili posteriori.
Gli altoparlanti
Nelle auto ci sono già, ma sono quasi sempre di qualità accettabile solo per ascolto di parlato o di musica da sottofondo, non per un ascolto impegnativo. Devono essere quindi tutti sostituiti. Gli altoparlanti hi-fi per auto sono progettati per gli stessi alloggiamenti standard e quindi la sostituzione non presenta problemi. Non si tratta però normalmente di una sostituzione con lo stesso tipo di componenti. Ad esempio sui canali posteriori, dove potrebbero essere stati montati di serie altoparlanti a larga banda, saranno installate unità coassiali a due vie con intuibili vantaggi.
Il subwoofer
È il componente che differenza maggiormente l'impianto rispetto a quello di serie consentendo una avvertibile estensione della riproduzione verso il basso. È anche il componente di più complessa installazione perché richiede per motivi fisici un volume di 13-15 litri e più, che vengono tolti inevitabilmente alla capienza del bagagliaio. Nelle berline e coupé il posizionamento tipico e nella cappelliera, ricavando però il volume nel bagagliaio con una struttura fissa. Più complessa la soluzione nel caso di una station wagon o di un mono volume o in ogni caso di auto con portellone posteriore e vano di carico trasformabile. Qui una struttura fissa limita in modo definitivo la flessibilità d'uso dell'auto. Per la mia auto precedente (una sw con capacità anche non molto ampia, Alfa 156 SW) la soluzione trovata, di compromesso, e stata una unità sub mobile di forma cilindrica, all'occorrenza staccabile). Ulteriore soluzione di compromesso sono i sub compatti installati nelle portiere posteriori, o sub "piatti" da mettere sul fondo del bagagliaio.
Da aggiungere che il sub ha il vantaggio, se tagliato molto in basso, di poter essere sistemato ovunque nell'auto, perché le frequenza inferiori non sono direttive e la sua posizione non è quindi percepibile.
Negli impianti più raffinati i sub possono essere anche due, il secondo più compatto posizionato nel cruscotto lato passeggero (a scapito del vano porta oggetti) potenziando così in modo più efficace anche i bassi fino ai 100Hz.
L'impianto di serie d'alta classe
Le vetture alto di gamma offrono spesso, tra le altre cose in più, anche un impianto audio dichiarato di qualità e solitamente curato (almeno a livello marketing) da nomi importanti dell'Hi-fi come B&O, Mark Levinson o Harmann Kardon. La BMW sulle serie6 e 7 monta ad esempio un impianto progettato da B&O con 16 altoparlanti attivi e processore digitale, sulla serie 3 impianti marcati Harman-Kardon con altoparlanti selezionati, la Lexus per le serie GS e LS monta impianti a 7+1 canali progettati da Mark Levinson.
Non sono sufficienti per un audio di qualità ?
Si è no. Garantiscono un ascolto migliore sicuramente, soprattutto grazie al fatto che gli altoparlanti non sono quelli di serie utilizzati per le produzioni di massa. Ma non possono raggiungere per limiti fisici le due prestazioni che caratterizzano un impianto custom e che, come abbiamo visto, richiedono spazio sottratto all'abitacolo: elevato livello di pressione sonora indistorta (finali) e estensione verso il basso (subwoofer). spesso
Nelle vetture alto di gamma citate difficilmente troverete finali ad alta potenza (non in classe D) dedicati e sub e quindi neanche queste prestazioni. Ma impianti con distorsione inferiore che possono beneficiare della silenziosità superiore (almeno se non si guida sui "sampietrini") di queste raffinate e costose autovetture.
 |
Nelle due immagini la sistemazione degli altoparlanti per i bassi e
per il canale centrale anteriore (a scomparsa) nell'impianto a 16
altoparlanti attivi con digital processing progettato dalla danese B&O
per le BMW Serie 6 e Serie 7 |
 |
Nella immagine sotto invece l a architettura dell'impianto a 15 vie e
19 altoparlanti progettato da Mark Levinson per la Lexus LS |
Il rumore di fondo e la dinamica
Un limite dell'ascolto in auto, come premesso, è il rumore di fondo. In una stanza di casa silenziosa o in una sala di concerto con pubblico disciplinato è intorno ai 35dB e quindi la gamma dinamica fino al massimo livello che possiamo sopportare (105dB o poco più) è dell'ordine dei 70dB (senza dimenticare mai che è una scala logaritmica e non lineare). Sufficiente per ascoltare anche le composizioni con le più ampie escursioni dinamiche, come una sinfonia per grande orchestra che passa da un pianissimo a un fortissimo (ad esempio il I movimento della IV di Beethoven). In un'auto ferma e col motore spento il rumore di fondo è dello stesso ordine di grandezza, ma muovendosi cresce e anche di molto. Il rumore è generato dal motore, dagli pneumatici con l'attrito di rotolamento, dalle sospensioni e quindi anche dal fondo stradale, dall'attrito aerodinamico e quindi anche dalla velocità, dall'eventuale apertura dei finestrini e in generale dalle caratteristiche dell'auto.
Ho fatto qualche misura sulla mia auto con il fonometro installabile sull'iPhone e si rileva che in velocità da città su fondo asfaltato normale si arriva già a 45dB, e si sale anche di 10dB se l'asfalto è quello drenante utilizzato ora largamente, che è certamente più sicuro ma una jattura per chi vuole ascoltare la musica in macchina. Ancora peggio se il fondo è sconnesso come purtroppo avviene in molte città italiane o addirittura sono usati ancora gli antistorici "sampietrini" (pavé) che difatti negli altri paesi sono usati solo nei centri storici pedonalizzati. Tranne che in Francia, ma sappiamo tutti che i francesi hanno le loro fisse.
Anche in velocità si perdono anche 20dB a velocità sostenuta ma ancora quasi legale e salendo a 180-190 si sale ancora di più (ma qui per ovvi motivi non ho fatto misure).
L'auto è una Mini BMW e quindi non la più silenziosa in commercio, caratteristiche medie. Macchine alto di gamma come quelle citate prima sono ovviamente più silenziose ma l'uso di ruote di grande diametro e la velocità superiore comporta anche in questo caso un inevitabile allontanamento dalla situazione "stanza di casa".
In sintesi in città con buon fondo possiamo contare su 50-55 dB di gamma dinamica teorica e in velocità o condizioni meno favorevoli si può scendere anche a 35dB o meno.
Che sono comunque considerazioni teoriche perché nella "stanza silenziosa" il rumore che comunque esiste non lo percepiamo, è eliminato mentalmente. Mentre il rumore del motore lo sentiamo, anzi lo ascoltiamo per decidere quando cambiare marcia o per verificare che tutto vada bene. In altre parole è una interferenza, qualcosa che si somma alla musica che tentiamo di ascoltare. Un po' come avviene per esempio in un ristorante o in un pub con musica dal vivo. In più, bisogna considerare che in auto neanche i livelli sonori troppo elevati sono praticabili per ovvi motivi di sicurezza, per la necessità di sentire senza ritardi i messaggi sonori di avviso esterni (clacson, sirene di ambulanze ecc.).
Per ascoltare musica in queste non favorevoli condizioni abbiamo quindi bisogno di un impianto in grado di produrre una pressione sonora indistorta elevata, per portare la musica fuori dal range dinamico dove sono presenti le interferenze. Per le condizioni ancora meno favorevoli, quando la gamma è troppo ristretta, è necessario però anche un compressore di dinamica, come
quello provato in un precedente post.
L'installatore
Lasciando il dubbio se l'impianto di serie sia sufficiente o meno ai fortunati possessori di BMW Serie 7 o Lexus LS, per tutti gli altri l'alta fedeltà per auto passa necessariamente per un impianto custom. Che richiede l'intervento di un installatore professionista, che progetterà l'impianto in base alle nostre specifiche esigenze e preferenze musicali, al livello di sacrificio che accettiamo rispetto agli altri usi dell'auto (vedi esempio precedente). Ovviamente i più esperti potranno anche scegliere di progettare l'impianto da soli (come si fa, non sempre con successo pieno, per l'impianto domestico) ma avranno già abbandonato da tempo questo post.
L'installatore si occupa anche, quasi sempre, di installazioni che con l'alta fedeltà hanno poco a che vedere, gli impianti SPL (Sound Pressure Level) da gara, una strana cosa su cui sorvoliamo, ma se non è troppo specializzato in questo settore può progettare anche impianti che puntano ai classici obiettivi dell'hi-fi: alta dinamica, bassa distorsione, estensione in frequenza verso i bassi. Si occuperà lui di tutto, naturalmente proponendovi diverse alternative, non solo la installazione, i cablaggio, le eventuali modifiche necessarie agli interni, ma anche la vendita di tutti i componenti (tranne quelli che magari avete già voi da una precedente installazione). Basandosi su consigli di amici, referenze su Internet, colloquio con lui e impressioni ricevute, il primo passo sarà quindi la scelta dell'installatore.
Il risultato finale
Cosa si ottiene dopo tutto questo dispiego di danaro e di tempo? Un risultato che può anche sorprendere chi pensa ad un impianto per auto come ad una soluzione di compromesso. Il mio installatore, giovane ma noto operatore del settore a Roma, mi raccontava di un suo cliente, peraltro figlio di un notissimo esponente della musica leggera italiana, che il giorno dopo l'installazione è tornato stupito e perplesso al laboratorio. Pensava che qualcosa non andasse bene, invece il cliente gli ha raccontato che era rimasto sino a notte tarda ad ascoltare l'impianto in auto, una utilitaria, per la cronaca, ascoltando sempre nuova musica, perché non riusciva a capacitarsi di ascoltare e scoprire dettagli in pezzi che conosceva, e che nel suo impianto di casa d'alta classe, tutto McIntosh, non era mai riuscito a sentire. E voleva capire come mai.
Una realizzazione in pratica
I post in questo blog, quando non sono analisi di scenario, derivano dalla esperienza pratica, e passiamo quindi a descrivere brevemente un impianto reale, e cosa si ottiene all'ascolto. Come accennato l'auto è una Mini BMW e il componente principale dell'impianto è un processore digitale Audison, che riceve in input l'uscita dell'impianto di serie, quindi in analogico, allo scopo di non modificare in alcun modo la dotazione di serie dell'auto. Nel processore digitale viene effettuata una conversione in digitale a 32 bit dei quattro canali standard, il processore consente poi di effettuare nel dominio digitale le funzioni di crossover, separando i contenuti audio in base alla frequenza per suddividerlo sulle tre vie dell'impianto, di bilanciamento tra i canali e le vie, e le funzioni di post-processing, ad esempio riposizionare con una linea di ritardo i due canali frontali per presentarli in modo corretto al guidatore, o modificare la risposta in frequenza per correggere anomalie nell'ascolto dovute alla particolare forma dell'abitacolo. Per ogni via (sub, medi e acuti) è previsto uno stadio dei due amplificatori multicanale utilizzati (Hertz e Proel per il sub). Tutti gli altoparlanti di serie sono stati sostituiti, come sempre è previsto in questi impianti. Per i posteriori, che di serie sono monovia, sono previsti due vie compatti con crossover passivo (JVC). Infine il sub, che per pura comodità è un componente passivo Proel di forma cilindrica all'occorrenza amovibile o spostabile. Non la soluzione ideale ma consente di mantenere ancora, seppur in parte, la funzionalità del piccolo bagagliaio della Mini moderna (quella storica e minuscola anni '60 lo aveva più grande ...). Gli altri componenti trovano posto sempre nel bagagliaio, spostando il kit per la riparazione della ruota (e riducendo inevitabilmente la dimensione utile). Anche se la descrizione può sembrare complessa è in realtà un impianto non troppo impegnativo rispetto ad altri, sia come impatto sull'abitacolo sia come costo.
Il risultato
Uno dei primi risultati che si ottengono con un impianto multicanale e multi via con crossover attivi è un basso tasso di distorsione, premessa per restituire tutti i dettagli del flusso sonoro. Questo si può apprezzare da subito con la musica acustica o con jazz ben registrato, ascoltando il gioco di piatti della batteria, e soprattutto con le voci maschili e femminili. Con il rock è notevole la possibilità di alzare il volume senza effetti udibili sino a livelli molto elevati sul tasso di distorsione. Altra sorpresa, soprattutto per gli amanti dei raffinati mini diffusori, è rappresentata dalla presenza di bassi profondi e indistorti, che consentono di ascoltare con grande precisione, ad esempio, un assolo di contrabbasso. La ricostruzione spaziale rimane invece l'obiettivo più difficile da raggiungere, come anticipato. Tranne che per impianti molto ambiziosi, con altoparlanti aggiuntivi, è alla portata soltanto la disposizione sul piano orizzontale. Che si apprezza comunque facilmente e con precisione in questo impianto. L'impianto è progettato per un ascolto in alta fedeltà e non d'effetto, quindi niente medio bassi profondi da far ascoltare alle altre auto in fila al semaforo. D'altra parte non ascolto né techno né heavy metal. Il sub è comunque il componente meno prestante dell'impianto, come anticipato, e quindi bassi molto profondi e immanenti rimangono fuori portata per un impianto così strutturato. E in generale richiedono maggiori ingombri.
In sintesi
Al prezzo di un restringimento degli spazi disponibili nell'abitacolo e soprattutto nel bagagliaio si potrà ascoltare con soddisfazione musica pop, rock, folk e jazz. Un po' più impegnativo l'ascolto di musica classica e sinfonica, ma in condizioni buone (auto silenziosa, strade ben tenute) saranno ascoltabili in modo soddisfacente anche questi generi musicali. Non ci sarà quindi nessun bisogno di limitarsi all'ascolto unicamente della musica super-compressa che producono ora le case discografiche (vedi post sulla "loudness war").
(il post è stato aggiornato in data 10/9/2013)


















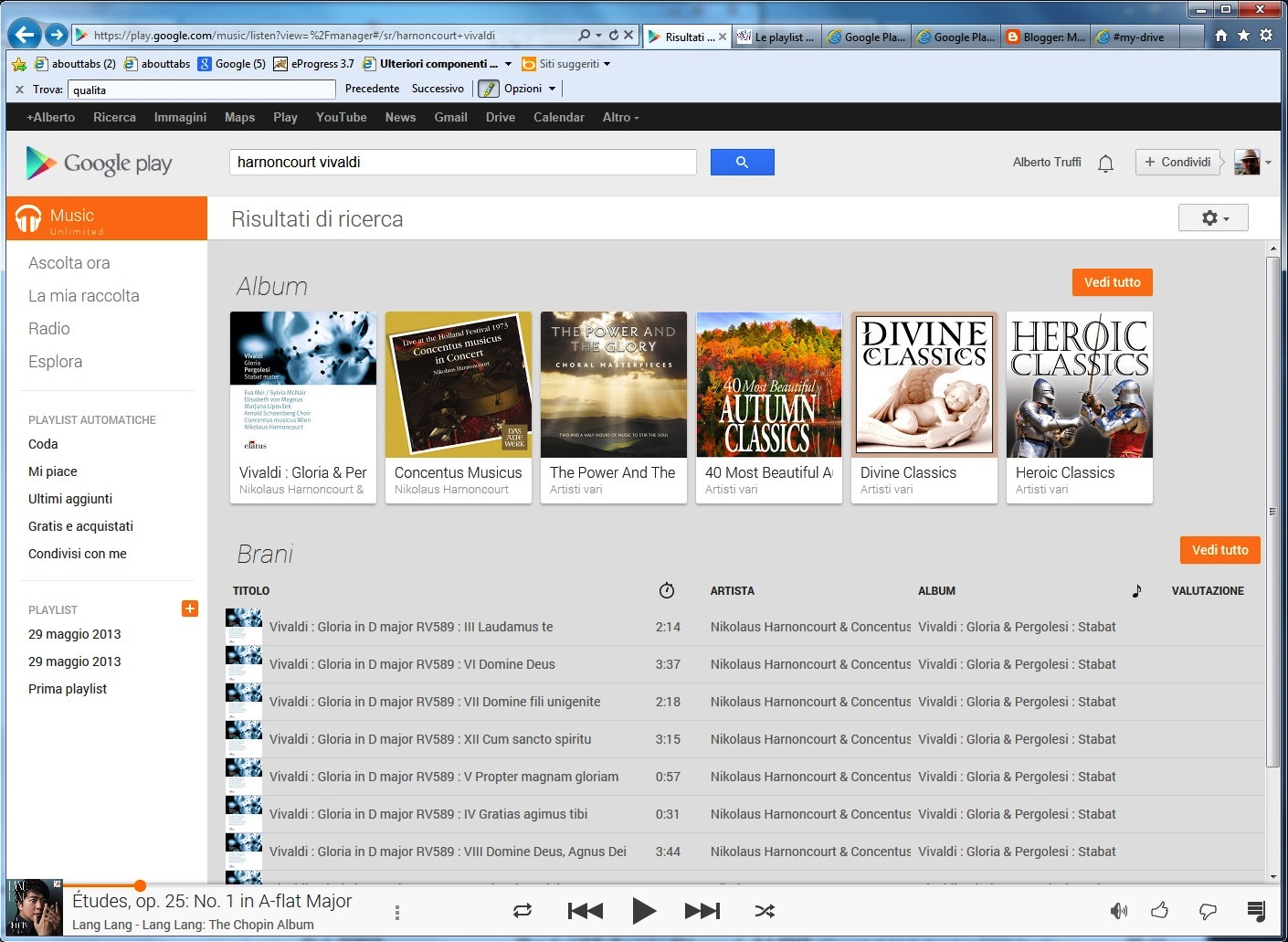




















.PNG)
.PNG)







.PNG)
.PNG)











